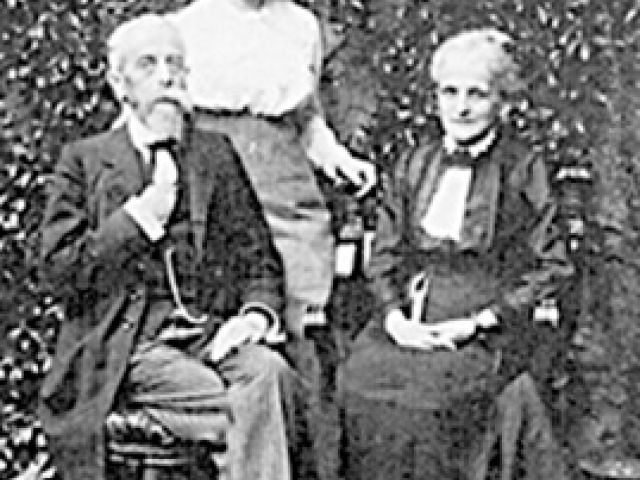Maria Schiratti, moglie dell’economista Giuseppe Toniolo, opera a Pisa dal 1879 al 1929 nell’ambito dell’associazionismo femminile cattolico con iniziative volte alla tutela e promozione della donna lavoratrice o in cerca di lavoro. Cofondatrice e presidente di alcune associazioni femminili pisane con finalità economico-sociali, la sua opera si distingue dalla semplice beneficenza poiché anticipa obiettivi e prestazioni proprie delle “politiche sociali” e di welfare a noi contemporanee, progettando iniziative – anche previdenziali e di protezione sociale – indirizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della donna; iniziative di carattere sia preventivo (volte alla formazione e alla sicurezza) sia riparatorio (volte a garantire le donne contro i rischi di infortuni sul lavoro, invalidità, malattia, maternità e disoccupazione). Il suo pensiero è vicino a quello di Toniolo, tuttavia ella si dedica quasi unicamente all’affermazione del valore della solidarietà economico-sociale che si realizza in primis attraverso il ruolo della famiglia, delle associazioni e istituzioni private (sussidiarietà orizzontale) e, solo in via ausiliaria, dello Stato (sussidiarietà verticale).
contesto familiare e formazione.
Schiratti, moglie dell’economista Giuseppe Toniolo, nacque il 10 aprile 1852 in Pieve di Soligo (TV) da Antonio (1809-1884) ed Emilia Arrigoni (1810-1886). I genitori, originari di Valdobbiadene, si sposarono nel 1836 ed ebbero undici figli, molti morti in tenera età. Nel 1834, Antonio aprì un laboratorio farmaceutico a Pieve di Soligo, dove si trasferì l’anno seguente per avviare l’esercizio della farmacia, attività proseguita dalla famiglia fino ai nostri giorni. Sostenitore di idee economico-sociali riformatrici, seppe conquistare la stima dei paesani tanto da essere nominato consigliere comunale nel 1840 e sindaco nel 1845, carica ricoperta per oltre trent’anni. Come amministratore, si spese per la modernizzazione e lo sviluppo economico e sociale del paese. A lui si deve infatti la fondazione di consorzi tra comuni per la realizzazione di nuove strade, il miglioramento della viabilità del paese, l’ampliamento del mercato settimanale locale e, non ultimo per importanza, il potenziamento dell’istruzione. Fermamente convinto «che solo l’istruzione potesse influire sulle nuove generazioni, creando una coscienza politica e sociale degna di un’Italia forte e unita» (Schiratti Giuseppe 1964, 51), animato da alto senso civico, vista l’insufficienza dell’istruzione scolastica locale, decise di potenziare gli istituti scolastici e, per non gravare sulle finanze comunali, si fece promotore di una pubblica sottoscrizione che portò alla costruzione di nuovi e più ampi edifici. Nel 1876 il paesino trevigiano di circa 3.760 abitanti[1] poteva contare su scuole comunali, scuole serali, festive, di disegno, di musica, di ginnastica e d’igiene veterinaria. Per suo merito Pieve di Soligo ebbe il telegrafo e fu il primo paese su suolo italiano ad ampliare il servizio postale istituendo la distribuzione della corrispondenza a domicilio e giornaliera (lug. 1851) (Salvioni 1883, 650-651). Come deputato provinciale di Treviso fu fautore delle condotte veterinarie, diede avvio a numerose istituzioni e a significative innovazioni agricole e industriali. Infine, si spese per il miglioramento delle condizioni di vita dei meno abbienti e per lo sviluppo e il consolidamento di varie opere benefiche.
Emilia Arrigoni è descritta dalla biografia tonioliana «Colta più di quanto lo fosse la generalità delle sue contemporanee» (Da Persico 1928, 38). La figlia Maria, Giovanni Battista Salvioni ed Elena Da Persico, prima biografa di Toniolo, ci hanno lasciato uno schizzo preciso di questa figura femminile di elevato spessore culturale. Per la figlia, la madre era dotata di «rettitudine e bontà d’animo», «senso del giusto», «squisita prudenza», «illuminato giudizio», «sincerità», «fermezza […] in tutte le sue convinzioni (ben meditate e perciò profonde), ma prima che tutto nei suoi principi religiosi», «coerenza» tra idee e azione, «aliena da esagerazioni», «saggia consigliera», «compassionevole coi poveri e specie cogli ammalati» (Schiratti 1888, 132-133) ma soprattutto era «una fonte di vera sapienza» (Schiratti 1888, 130). Per Salvioni – che sposerà l’ultimogenita Rosa Schiratti nel 1888 – Emilia era «donna di fede antica, di rara sagacità, […], che sapeva accompagnare una prudente riservatezza a molta franchezza di consigli e di risoluzioni dove occorresse» (Salvioni 1898, 2). Ella, scrive Salvioni, si distingueva «per vivacità d’ingegno, sodezza di cultura, per una squisita abilità nella cristiana educazione della prole, doti morali non iscompagnate dalla genialità della persona» (Salvioni 1898, 7). Infine, Da Persico sottolinea come Emilia dedicasse alla lettura almeno un’ora ogni giorno, ma «lo studio non era per lei l’acquisto di un affastellamento di cognizioni; sì piuttosto il mezzo per formarsi un proprio giudizio e una visione vasta degli avvenimenti umani» (Da Persico 1928, 38). Ella, infatti, seguiva con occhio attento i tempi nuovi, leggeva i giornali, si teneva informata sugli avvenimenti pubblici, amava la storia antica ma seguiva con interesse quella contemporanea, partecipava ai discorsi di politica nazionale e internazionale, aveva una predilezione per l’Irlanda e si mostrava entusiasta di O’Connel e della lotta per l’indipendenza dall’Inghilterra (ibid., 38-39).
Dei tre fratelli – Gaetano, Renato e Tomaso – i primi due erano compagni di studi di Toniolo alla Facoltà politico-legale dell’Università di Padova e ne frequentavano abitualmente la casa. Gaetano (1845-1906) è forse il più conosciuto: fu tra i primi sostenitori delle opere cooperative di Luigi Luzzatti e fu fondatore della Banca popolare di Pieve di Soligo (1871), prima banca popolare della provincia di Treviso. Nel pensiero di Gaetano, il costituendo istituto bancario avrebbe dovuto essere «mezzo […] di moralità e prosperità economica» del territorio, rispondere al «bisogno di soccorrere al commercio, all’industria e alla piccola possidenza», sollevando tali settori «dall’incubo dell’usura sfrenata, dell’ipoteca e dell’umiliazione» (Schiratti Gaetano 1872, 3). Fu anche fondatore della Latteria sociale di Soligo (1883), tutt’ora in attività. Come il padre, divenne sindaco di Pieve di Soligo (1885-1890) e consigliere provinciale (1890-1895), ma ricoprì anche la carica di deputato del Regno d’Italia (1892-1900). Dal canto suo, Renato intraprese la carriera notarile, fu componente del Consiglio di Amministrazione della banca popolare fondata dal fratello, sostenitore di opere benefiche nonché cultore appassionato di studi storici. Di Tomaso (1849–1934) si sa che insieme ai fratelli fu tra i promotori della costituzione del Sindacato agrario di Pieve di Soligo (1890), nella forma di società anonima cooperativa per azioni.
Le sorelle – Pia (1847-1875), Teresa, Maria e Rosa (1856-1897) – sono descritte «distinte delle migliori doti e ben istruite» (Vistalli 1954, 80). Non ci sono notizie precise sulla formazione di Maria, tuttavia sappiamo con certezza che Rosa ottenne la patente di maestra elementare (Salvioni 1898, 5) e, con molta probabilità, anche le altre sorelle completarono studi almeno di pari grado, poiché lo stesso Salvioni delinea con precisione l’alto livello di cultura e d’istruzione delle Schiratti: conoscevano almeno tre lingue, la storia dell’arte, l’architettura, la letteratura, la musica, la floricoltura e altro ancora. Dinamiche e impegnate anche fuori dall’uscio di casa, le Schiratti crebbero in un ambiente nel quale, posto a direzione principale della vita lo spirito della religione, questo non riuscì d’ostacolo, ma di stimolo ad opere di civile progresso, si accompagnò ad un sincero patriottismo, ad una cultura varia e non superficiale. […] I nostri Schiratti, dotati di una mobilità congenita, […] visitarono non solo l’Italia, ma anche Monaco, Parigi, Londra e perfino l’Olanda, ravvivando le domestiche conversazioni di copiosi ricordi e descrizioni, […] aprendo l’animo ad un largo concetto della vita, l’intelligenza educando ad una certa raffinatezza di gusto artistico, interessandosi di continuo al progresso scientifico ed al movimento letterario del paese. Le sorelle si avvantaggiarono di questa educazione continuata, meglio sperimentale che didattica, e per conto loro coltivarono lo spirito con letture molte, sempre appropriate alle abitudini religiose e costumate della famiglia, coltivarono le lingue straniere. (ibid., 3-4)
Oltre ai fratelli, anche le sorelle compirono numerosi viaggi visitando le maggiori città d’arte d’Italia e portando a termine impegnative escursioni alpinistiche sulle Dolomiti (ibid., 8, 11).
In conclusione, Maria Schiratti crebbe in una famiglia della media borghesia veneta, in un ambiente colto, di alto senso civico e promotore di numerose opere economico-sociali tanto che, a dire di Salvioni, divenne «il centro intellettuale del paese» (ibid., 17). A questo ambiente, particolarmente attento anche al bene comune, si aggiunse con gradualità la figura di Toniolo il quale, a dire della Da Persico, trovò in questa famiglia non solo un più intimo e forte attaccamento al cattolicesimo, ma anche quelle abitudini di studio e di raccoglimento di cui abbisognava; abitudini radicate che sembra difettassero nella famiglia di origine (Da Persico 1928, 37, 40). Poiché centro propulsore, intellettuale e religioso, della famiglia Schiratti era una donna, Emilia Arrigoni, si legge che Toniolo s’intratteneva perciò volentieri con lei, e s’interessava vivamente a tutto lo svolgersi di vita di quella famiglia, dove la attenzione materna alla cosa pubblica diveniva negli uomini partecipazione attiva ad essa. (Ibid., 40)
Maria Schiratti conobbe il futuro consorte nell’estate del 1864 (Vistalli 1954, 78) o del 1867 (Da Persico 1928, 38), durante il soggiorno estivo di Toniolo alla Pieve, ospite dei fratelli. Nel novembre 1877 ebbe inizio il fidanzamento che si suggellò con il matrimonio (4 set. 1878). Del fidanzamento ci rimangono tredici lettere di Toniolo alla fidanzata (dal 13 nov. 1877 al 9 giu. 1878), dalle quali si ricava la profonda sintonia che legava i due giovani: una intesa culturale, di fede e di principi. Alcune lettere permettono di delineare la personalità della Schiratti e ci mostrano il suo interesse autentico agli studi economici del fidanzato (Toniolo 1878, 25, 30-32, 33). La corrispondenza ci rivela inoltre le letture di Schiratti, svolte in autonomia o in consonanza con Toniolo, oltreché gli autori di interesse comune: Frédéric E. Chassy, Edmondo De Amicis, Giambattista Giuliani, Guglielmo A. Audisio, Alessandro Manzoni, Carlo Maria Curci, Gioacchino Ventura, Leonardo Perosa, Samuel Smiles, Augusto Conti, Girolamo Boccardo, Frédéric Le Play, Henry Charles Périn, Tommaso d’Aquino, Louis Blanc, Girolamo Galassini, Leone XIII e molti altri. Entrambi erano estimatori dei versi di Giacomo Zanella[2], poeta veneto assai amato dalla famiglia Schiratti. I due scrivevano di avvenimenti dell’attualità religiosa e politica (la morte, nel 1878, di Vittorio Emanuele II e di Pio IX, oppure i congressi delle Banche popolari, ecc.), oltre che di temi economici: alcuni teorici (come il salario o le teorie di Malthus) altri più concreti, come l’origine della miseria e della povertà, questi ultimi particolarmente sentiti da Maria Schiratti.
Nell’anno successivo all’ottenimento della cattedra all’Università di Modena di Toniolo (marzo 1878), i due sposi si trasferirono a Pisa, dove Toniolo insegnò Economia politica fino al 1918. Ivi nacquero i loro sette figli, tre dei quali morirono in tenera età (Vistalli 1954). Dalla loro unione – fatta di sintonia di fede, principi, interessi e finalità – ognuno dei due coniugi trasse impulso per una “buona e proficua operosità” (Da Persico 1928, 79; Vistalli 1954, 77-78). Partecipe a convegni, congressi e viaggi insieme al marito, Schiratti si mostrava attenta e appassionata alle iniziative e alle battaglie che vedevano Toniolo protagonista. Luigi Forlivesi, allievo di Toniolo, nel delineare il ricordo del maestro non poté esimersi dal parlare di lei:
Dobbiamo dire, per ragioni di completezza e per doveroso omaggio alla realtà storica, che Giuseppe Toniolo non fu solo nel suo lungo cammino […]. Questa donna è stata senza dubbio l’aiuto più prezioso che Toniolo potesse sperare: donna semplice e pia, […] vivace e intelligente, tanto che i suoi interventi nelle conversazioni, senza sfoggi di erudizione e senza pretese intellettualistiche, erano sempre sensati e pertinenti. (Forlivesi 2005, 111)
Si ravvisa pertanto una figura di donna forgiata dall’ambiente famigliare. Infatti, da un lato, sull’esempio della madre, ella fu saldamente radicata nei principi e nei valori della tradizione veneta e della fede cattolica, possedeva un livello di istruzione molto superiore alla media della popolazione italiana[3], era inoltre particolarmente attenta alle vicende dell’attualità nazionale e alle trasformazioni economico-sociali del suo tempo. Dall’altro lato, come si vedrà, sull’esempio del padre e dei fratelli ella si dedicherà con intelligenza e solerzia all’impegno nel sociale con iniziative economiche coerenti con un preciso modo di vedere la famiglia e l’ordine sociale.
esperienze fondamentali, attività, opere, imprese o iniziative a carattere economico.
L’attività di Maria Schiratti si colloca nell’ambito del movimento femminile cattolico pisano; tuttavia, ella non ignorò il contesto nazionale o internazionale. Si può infatti supporre che si sia avvicinata al movimento femminile cattolico nazionale in modo mediato, essendo – come abbiamo visto – interessata e partecipe alle vicende che coinvolgevano Toniolo (Manzalini 2024, 111-116). Di fronte alle posizioni emerse in quegli anni nel movimento femminile cattolico – soprattutto a seguito del convegno nazionale organizzato da Adelaide Coari (Milano, 25-27 apr.1907) e del primo Congresso nazionale delle donne italiane indetto dal CNDI (Roma, 23-30 apr. 1908) – Schiratti mostra di non condividere l’opinione della corrente minoritaria eterodossa con tendenze individualistico-egualitarie sostenuta da Coari (1881-1966), Carlo Grugni e Romolo Murri. Ella manifestò il proprio dissenso nei confronti della posizione della Coari, difforme dalle indicazioni ecclesiastiche, fino a disapprovare il giornale da lei diretto (Pensiero e Azione, 1904) (Toniolo 1953, 161-163). Al contrario, sostenne la posizione di Elena Da Persico (1869-1948), dal 1904 direttrice di Azione muliebre, con la quale instaurò un rapporto di collaborazione e di profonda amicizia (Passoni 1991).
Benché interessata alle vicende nazionali, fu soprattutto a livello locale che Schiratti espresse le sue idee e mise a frutto le sue capacità organizzative. Infatti, a Pisa, insieme all’amica Teresa Marcello[4], divenne la massima rappresentante del movimento femminile cattolico (Fusano Guarini, Galoppini, Peretti 2006, 101) e si impegnò per la nascita e lo sviluppo di un associazionismo femminile di tipo ‘moderno’ (Gaiotti De Biase 1963). Nel capoluogo toscano ella partecipò a numerose iniziative promosse dall’ambiente cattolico e fu cofondatrice, insieme a Teresa Marcello e a Luisa Scotto Corsini, di un asilo cattolico realizzato in alternativa all’asilo laico cittadino (Scardozzi 2006, 190-191). Nel 1904, insieme a Toniolo e ad altre signore fondò il Comitato pisano dell’Associazione cattolica internazionale delle opere di Protezione della giovane. Nel 1907 fu nominata componente della direzione diocesana delle associazioni femminili (Marino 1995-1996, 105). Nel 1908 presiedette il convegno pisano delle associazioni femminili. Dopo il 1909 fu nominata vicepresidente dell’Udci, cassiera delle Dame della carità (1911), componente della Federazione delle Opere femminili cattoliche di Pisa, presidente delle Chiese povere e responsabile della Società cattolica fra le tessitrici di San Sisto al Pino[5] (Marino 1995-1996, 120-126). Le sue iniziative – sostenute dall’arcivescovo Pietro Maffi – non furono però, come si potrebbe presumere, di natura assistenziale o caritativa, ma ebbero carattere e finalità economico-sociali, essendo rivolte anzitutto a donne lavoratrici o in cerca di lavoro, alla loro formazione culturale e professionale, al loro miglioramento economico-sociale e alla loro sicurezza (fisica, morale ed economica).
Tra le molte organizzazioni femminili da lei seguite, Schiratti si dedicò principalmente al Comitato pisano dell’Associazione cattolica internazionale delle Opere per la Protezione della giovane della quale fu presidente o vicepresidente dal 1908 al 1928. L’associazione traeva origine dall’Oeuvre catholique suisse pour la protection de la jeune fille fondata da Louise de Reynold (Friburgo, 1896) con lo scopo di aiutare le giovani elvetiche migranti e far fronte al fenomeno della cosiddetta “tratta delle bianche”[6]. Nel 1897 l’associazione divenne internazionale e prese il nome di Oeuvre catholique international pour la protection de la jeune fille. All’inaugurazione, avvenuta a Friburgo nell’agosto 1897, era presente Giuseppe Toniolo (Schiratti 1913, 45). Nel 1902, quest’ultimo, Rodolfo Bettazzi[7] e un gruppo di donne (tra le quali Carolina Cassinis e Marianna Bondi Bettazzi) fondarono a Torino il Comitato locale dell’associazione che divenne nazionale nel 1903. L’associazione ebbe ampia diffusione su tutto il territorio nazionale (Bettazzi 1912, 1939; Lanzavecchia 1985; Salini 2011, 199-200). Nel gennaio 1904 Schiratti, Toniolo e altre signore fondarono il Comitato pisano. La nuova associazione cattolica, a differenza di altre simili[8], era nata per fini più ampi della difesa delle migranti e la lotta alla tratta. Suo scopo era, come scrive Schiratti, che le giovani lavoratrici o in cerca di lavoro «fossero più ancora protette e sorrette non solo nei viaggi; ma in qualunque altro modo» (Schiratti 1913, 45). L’associazione intendeva pertanto fornire alle donne lavoratrici o in cerca di lavoro, non solo protezione e assistenza, ma anche strumenti che ne favorissero la crescita personale (morale, sociale, economica e professionale). L’attenzione ai concreti e reali bisogni delle donne lavoratrici o in cerca di lavoro, non solo migranti, caratterizzò l’impegno civico, economico e sociale di Schiratti a Pisa.
Le iniziative e le opere realizzate dal Comitato pisano durante i primi venticinque anni si ricavano dalle cinque Relazioni redatte dalla Schiratti in qualità di presidente o vicepresidente (Schiratti 1908, 1913, 1922, 1925, 1928) e mostrano l’enorme lavoro di solidarietà e promozione svolto in favore delle donne lavoratrici o disoccupate. Ricordiamo, a titolo di esempio, l’apertura di refettori per le operaie; i doposcuola per i bambini; la scuola di canto per le operaie; la scuola della ‘Buona massaia’; l’assistenza delle ragazze alla stazione; l’attivazione di un servizio di trasporto notturno in vettura per le operaie; la costituzione di una Società di mutuo soccorso per operaie le quali ricevevano un sussidio in caso di malattia, sussidi dotali o puerperali[9]; l’organizzazione di momenti di intrattenimento (conferenze, giochi o passeggiate) per le operaie e le domestiche; la vigilanza delle donne impiegate in lavori pericolosi o insalubri; l’ufficio di collocamento per le domestiche; gli incontri domenicali per l’insegnamento del catechismo; le lezioni di Economia domestica; il corso artistico itinerante per le lavoratrici; le visite alle carcerate e il loro collocamento lavorativo una volta uscite di prigione; la scuola di religione per donne (dal 1906); gli esercizi spirituali domenicali per le domestiche; l’assistenza alle pericolanti; l’assistenza alle profughe di guerra; la scuola di calzoleria; la casa estiva per le operaie (Marina di Pisa); una società cooperativa di lavori a domicilio; una lavanderia con riparazione degli indumenti e, infine, la Casa famiglia.
Per quanto riguarda il pensiero economico, dalle cinque Relazioni redatte dalla Schiratti è possibile ricavare alcune tracce del suo modo di vedere l’economia. Nella ii Relazione Schiratti rifletteva sul fenomeno della ‘tratta delle bianche’, ragionava sulle cause economiche e sociali del problema, osservava come molti fossero condotti a emigrare «attirati con miraggi di ricchezze improvvisate e di felicità» e come le donne fossero spesso preda di una «congiura di speculatori infami di carne umana, […] stretti in una società mondiale allo scopo di arrolare donne e fanciulle per indurle ad espatriare in cerca di lavoro», collocandole in fabbriche o nei servizi domestici, ma «senza alcun riguardo ai pericoli morali, ai contatti, agli sfruttamenti dei capitalisti, lucrando essi sull’ufficio di intermediari» (Schiratti 1913, 44)[10]. Secondo Schiratti questo fenomeno sociale aveva le caratteristiche di «un mercato innominabile e ributtante» in cui «trafficanti inumani» riuscivano a sottrarsi «alla vigilanza di ogni autorità e legge». A suo modo di vedere, gli strumenti legislativi non erano però sufficienti ad eliminare questo mercato, servivano infatti «vaste e salde istituzioni private in ogni nazione» di destinazione che agissero in modo capillare per recidere quella rete di sfruttamento. Schiratti riteneva anche necessaria un’opera preventiva nei paesi di origine che scoraggiasse le giovani a migrare. A tal proposito, rispetto alla concentrazione in fabbrica di giovani donne, era per lei preferibile il potenziamento del lavoro a domicilio nei paesi d’origine, un tipo di lavoro che, ai suoi occhi, necessitava di essere riformato e reso maggiormente remunerativo per le lavoratrici. Infatti, in primo luogo, era necessario istituire «un ufficio di lavoro per procurare lavoro a domicilio» e una scuola professionale per insegnare questi lavori, in secondo luogo, occorreva costituire delle cooperative di produzione le cui socie, interponendosi «tra i commercianti e le lavoratrici», avrebbero potuto ottenere materie prime a minor costo e fornire salari competitivi rispetto a quelli delle operaie in fabbrica. Nella La iv Relazione (Schiratti 1925, 65-67)[11] rifacendosi agli interventi esposti alla xi Settimana sociale di Torino (1924), ribadiva l’importanza per le donne di agire in modo organizzato poiché «i socialisti riescono in qualche luogo ad organizzare anche le donne e come!!». Per Schiratti ogni impegno sociale per essere efficace necessitava di attenta preparazione, accurato studio[12] e un’azione organizzata in associazioni. Oltre a ciò, riteneva importante evidenziare la differenza tra le organizzazioni femminili socialiste e quelle cattoliche: «se i socialisti insegnano soltanto i diritti, le organizzazioni cattoliche si interessano anche dei doveri ed è per questo che la nostra organizzazione non deve essere di lotta di classe, ma di armonia di classi.» (Ivi, 65). Limitata la finalità liberal-individualistica (richiesta di soli diritti) ed esclusa quella social-egualitaria (dialettica tra classi o sessi), Schiratti esortava pertanto alla formazione di organizzazioni operaie femminili in forma di Unioni professionali poiché questo tipo di istituzioni, abolite dalla Rivoluzione francese, «asseconda la natura umana». A suo modo di vedere, le Unioni perseguivano infatti un triplice scopo: dare una rappresentanza collettiva alla classe lavoratrice, farne valere i diritti e garantire l’adempimento del dovere di promuovere il miglioramento materiale, civile e spirituale degli associati. Ricordava infine che l’azione pratica, individuale ed associata, avrebbe dovuto sempre essere ispirata dallo spirito cristiano e accompagnata dallo studio
Importa quindi studiare tecnicamente e praticamente le condizioni delle operaie onde effettuare le organizzazioni professionali, onde le nostre giovani non siano costrette ad aderire alle Leghe socialiste per essere protette dai soprusi, compromettendo la loro fede e la loro morale. (Ivi, 67)
Gli strumenti da lei scientificamente progettati si rifacevano, in primo luogo, al self help sociale, all’associazionismo e alla cooperazione (mutual help), alla sussidiarietà orizzontale e, solo in via ausiliaria, a quella verticale. La tutela di coloro che la giurisprudenza costituzionale italiana definisce “soggetti deboli”[13] (Bellocci, Passaglia 2006) – come le donne, i bambini e le migranti – era da lei concepita come esplicazione del dovere solidaristico che gravava su ogni persona in quanto essere naturaliter sociale. Il principio di solidarietà, da lei inteso come impegno nei confronti del “soggetto debole”, trovava concreta attuazione nella rimozione di quegli ostacoli che impedivano o limitavano il pieno sviluppo della persona umana (uguaglianza sostanziale). Per tali motivi, gli interventi da lei progettati e realizzati per donne lavoratrici o disoccupate riguardarono sia la predisposizione di canali preferenziali di accesso al lavoro, sia strumenti previdenziali, sia strumenti preventivi di tipo culturale e formativo, sia strumenti assistenziali.
Sembra pertanto riduttivo descrivere la Schiratti solo come un “angelo del focolare”, una “compagna devota del marito” o una “donna colta e pia”. Dai documenti di archivio e dai pochi scritti si scopre «una Maria Toniolo sconosciuta», ignorata dalla storiografia, «partecipe delle battaglie combattute dalle donne cattoliche dei primi anni del secolo e delle iniziative poste in atto» (Tramontin 1991, 6). Una figura, sempre rimasta nell’ombra, che merita di essere ricordata non solo sotto l’aspetto devozionale, poiché progettò e realizzò opere economico-sociali moderne, riconducibili a quello che oggi è denominato sistema di welfare mix dove, nell’ordine, famiglie, mercato, associazioni e, in ultima istanza, lo Stato cooperano sulla base del principio di sussidiarietà in favore dei “soggetti deboli”.
rete dei rapporti instaurati, fortuna e influenza del personaggio e della sua opera.
Dagli scritti e dai documenti d’archivio, possiamo ricavare le finalità dell’attività di Schiratti. Se fine prossimo era l’aiutare la donna lavoratrice o migrante in ogni aspetto della sua esistenza, nella consapevolezza che il sistema industriale di fabbrica sacrificava e attentava alla sua salute (non solo fisica), fine ultimo era il «contribuire alla formazione di famiglie oneste e cristiane» (Schiratti 1922, 51-58) poiché, a suo modo di vedere, la famiglia cristiana, ossia “famiglia normale” nel pensiero tonioliano, era l’istituto fondante l’ordine sociale, istituzione messa in pericolo sia dal moderno sistema di fabbrica sia dal socialismo. Per raggiungere tali scopi era per lei necessario non solo studio continuo e azione, individuale e associata, ma anche una fitta rete di donne legate da idee e valori condivisi poiché, «le anime buone e intelligenti è bene si incontrino, si vedano e s’intendano per maggiormente diffondere le buone idee»[14]. Per questo Schiratti intrecciava e allargava, in prima persona o per mezzo del marito, una fitta rete di relazioni con singole donne, con esponenti dell’associazionismo femminile, con mogli di corrispondenti o colleghi di Toniolo, con madri di allievi del marito e con esponenti della gerarchia ecclesiastica. Schiratti intrattenne anche rapporti a livello internazionale con comitati esteri dell’associazione da lei presieduta. Nell’archivio Toniolo di Pisa sono conservati, ad esempio, il rapporto della Ligue catholique féminine de Hongrie del 1925 e il rapporto dell’Union des dames catholiques mexicanes (anni 1922-25).
In merito alla fortuna e all’influenza del personaggio e della sua opera, possiamo affermare che, sebbene Schiratti sia stata quasi dimenticata dalla storiografia, alcune sue iniziative sono rimaste operanti fino ai nostri giorni. Si fa riferimento al Comitato pisano dell’Associazione delle Opere di protezione della giovane, oggi denominata Associazione Cattolica internazionale al Servizio della Giovane (Acisjf), il cui Comitato pisano e la casa-famiglia sono a lei intitolati (Acisjf-Casa della giovane Maria Schiratti Toniolo, Onlus).
[1] cfr. Censimenti popolazione Pieve di Soligo 1871-2021.
[2] Giacomo Zanella (1820-1888) fu una figura rappresentativa della cultura italiana veneta dell’Ottocento. Sacerdote, docente universitario di Letteratura italiana e Magnifico rettore dell’Università di Padova (1871-72). Tra i suoi studenti si ricordano Fedele Lampertico, Luigi Luzzatti e Antonio Fogazzaro. Le sue poesie avevano a oggetto gli affetti famigliari, la natura, la storia, la condizione dei migranti e il progresso scientifico, affrontato però dal punto di vista psicologico dello scienziato che non vede contraddizione tra scienza e fede.
[3] Dalle statistiche storiche dell’Istat si apprende che nel 1861 il tasso di analfabetismo tra le donne superava l’80% e quello degli uomini era quasi il 70%. Nel 1878, anno del matrimonio Schiratti-Toniolo, la percentuale di donne che non sottoscrissero l’atto di matrimonio perché non in grado di scrivere era del 70%. (cfr. https://www.istat.it/it/files//2019/03/cap_7.pdf, visitato il 10/07/2024).
[4] Teresa Marcello (1862-1946), di antica famiglia dell’aristocrazia veneziana, giunse a Pisa nel 1881, sposa del conte Alfredo Agostini Venerosi della Seta. Cara amica di Cora di Brazzà Sarvognan, promuove il comitato pisano delle Industrie Femminili Italiane (Pucci 2022, 93-129) e organizza un gruppo di lavoranti per la ripresa del ‘punto pisano’. Molte sono le iniziative promosse da Teresa Marcello, alcune in collaborazione con Maria Schiratti. Ricordiamo: l’Opera delle scuole serali gratuite per i piccoli Operai di Pisa; il Comitato promotore piccoli Operai di Pisa; il Comitato promotore Femminile per la fondazione dell’Asilo infantile a Lari; il Patronato per gli alunni poveri delle scuole elementari; il Circolo Artigiano di Mutua Assistenza in Palaja; l’Associazione di mutuo soccorso e previdenza fra gli Insegnanti della provincia pisana (Marino 1995-1996, 140).
[5] Il Ministero di agricoltura, industria e commercio si riferisce all’organizzazione con il nome di Cooperativa di lavoro della Unione professionale cattolica tessitrici di San Sisto al Pino (Ministero di agricoltura, industria e commercio 1911, 171).
[6] La tratta delle bianche fu, a quel tempo, una grave questione sociale emersa con le grandi trasformazioni economiche di metà Ottocento e la cosiddetta “prima globalizzazione” (Toniolo Gianni 2013; Harold, O’Rourke 2011). Lo sviluppo del moderno sistema di fabbrica, la richiesta di manodopera a basso costo, una tendenza al libero scambio e i miglioramenti nel trasporto internazionale, favorirono lo spostamento di ingenti masse di donne e ragazze in cerca di lavoro che aveva tutte le caratteristiche di “traffico” di esseri umani. Il significato dato ai nostri giorni di “tratta delle bianche” sembra discostarsi da quello abitualmente utilizzato nell’Ottocento.
[7] Rodolfo Bettazzi (1861-1941), è professore di matematica ed esponente del movimento cattolico torinese, fondatore di diverse organizzazioni quali la Lega per il riposo festivo e la Lega per la moralità.
[8] Per combattere il fenomeno della tratta vennero realizzate alcune iniziative a livello internazionale, promosse dall’associazionismo filantropico o confessionale e, solo in seguito, dagli Stati. In Inghilterra viene fondata l’associazione filantropica e abolizionista National Vigilance Association (1885), in Svizzera viene fondata l’associazione protestante Union internationale des amies de la jeune fille (1877). La Germania fu il primo Stato a introdurre nella legislazione il contrasto alla Tratta (1897). Solo nel 1904, con la conferenza di Parigi, i delegati dei governi e di diverse associazioni, firmarono un accordo per predisporre una normativa internazionale di contrasto alla tratta di donne e minori.
[9] Cfr. il Modulo di iscrizione alla Società di Mutuo soccorso riportato in copia anastatica da Marcesini (2014, 39-40).
[10] La Relazione, non datata, è presumibilmente del 1913 poiché in essa si ricorda la fondatrice, Madame de Reynold, scomparsa nel mar. 1912. (Marcesini 2014, 21).
[11] La Relazione è senza data ma, come rileva Marcesini (2014, 22), ragionevolmente del 1925 poiché in essa Maria parla della xi Settimana sociale di Torino (14-19 dic. 1924).
[12] A Pisa organizza lezioni a contenuto sociale, economico e sociologico finalizzate alla formazione delle donne desiderose di impegnarsi in opere di solidarietà. Relatori delle lezioni sono anche donne, come al Marianna Bondi Bettazzi vicepresidente della sezione cultura dell’UDCI oppure l’amica Elena Da Persico, entrambe componenti dei Comitati locali dell’Associazione internazionale di Protezione della giovane.
[13] Nel 1902 Giuseppe Toniolo, scrisse in merito alla legislazione italiana sul lavoro notturno indicando donne e fanciulli come «persone più deboli» e pertanto «meritevoli di speciale protezione» (Toniolo Giuseppe 1902).
[14] Lettera di Maria Schiratti Toniolo a Marianna Mazzei, 16 mar. 1912 (Archivio Famiglia Mazzei, b. 2).
OPERE
Pubblicazioni
- 1888. “Nonna Emilia Schiratti”. In Maria Schiratti; Giuseppe Toniolo. Nonna Emilia e nonna Isabella. Alcune pagine di un diario domestico diretto ai nostri figli. Pubblicato in Giuseppe Toniolo. 1952. Scritti spirituali religiosi familiari e vari. Comitato Opera Omnia di G. Toniolo. Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, pp. 130-144.
- 1908. I Relazione, 14 marzo 1908. Relazione generale dell’Op. Catt. Int. Prot. G. In Donatella Marcesini (a cura di). 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa, Pisa, Pacini, 2014, pp. 33-38.
- 1913. II Relazione. In Donatella Marcesini (a cura di). 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa, Pisa, Pacini, pp. 43-48.
- 1922. III Relazione. Scritta dopo la morte di Benedetto XV, 22 gennaio 1922. In Donatella Marcesini (a cura di). 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa, Pisa, Pacini, pp. 51-58.
- 1925. IV Relazione. In Donatella Marcesini (a cura di). 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa, Pisa, Pacini, pp. 65-67.
- 1928. V Relazione, 30 gennaio 1928. In Donatella Marcesini (a cura di). 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa, Pisa, Pacini, pp. 73-87.
Attività a carattere economico
- Attività e istituzioni di welfare rivolte alle donne lavoratrici o in cerca di lavoro
Traduzioni
Manoscritti e altri documenti
BIBLIOGRAFIA
- Bellocci Mario; Passaglia Paolo. 2006. La tutela dei ‘soggetti deboli’ come esplicazione dell’istanza solidaristica nella giurisprudenza costituzionale. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU%20191_Tutela_soggetti_deboli.pdf Accesso 26/07/2024.
- Bettazzi Rodolfo. 1912. La protezione della giovane. I, 3. Torino, L’azione sociale popolare.
- Bettazzi Rodolfo. 1939. Trentasette anni di vita della Associazione Cattolica Internazionale delle Opere per la Protezione della Giovane in Italia. 1902-1938. Roma, Arti Grafiche Sansaini e C.
- Da Persico Elena. 1928. La vita di Giuseppe Toniolo. Mantova, Gruppo buona stampa.
- Forlivesi Luigi. 2005. “Giuseppe Toniolo nel ricordo di un allievo”. In Romano Molesti (a cura di), Giuseppe Toniolo. Il pensiero e l’opera. Milano, FrancoAngeli, pp. 105-112.
- Harold James; O’Rourke Kevin. 2011. “L’Italia e la prima globalizzazione, 1861-1940”. Quaderni di Storia Economica. n.16, Banca d’Italia (ottobre).
- Fusano Guarini Elena; Galoppini Annamaria; Peretti Alessandra (a cura di). 2006. Fuori dall’ombra. Studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli XIX e XX), collana Studi Pisani Cultura e società, 24. Pisa, Plus.
- Gaiotti De Biase Paola. 1963. Le origini del movimento cattolico femminile. Brescia, Morcelliana.
- Lanzavecchia Renato. 1985. “Una proposta di ricerca: l’Opera per la protezione della giovane”. Bollettino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia. XX, 1, pp. 153-160.
- Manzalini Fiorenza. 2024. “L’impegno economico sociale di Maria Schiratti Toniolo a Pisa”. Il pensiero economico italiano. 32(1), pp. 109-126.
- Marcesini Donatella. 2014. Maria Schiratti Toniolo e la Casa della Giovane di Pisa. Pisa, Pacini.
- Marino Maria Elisabetta. 1995-1996. L’associazionismo femminile cattolico a Pisa dal 1904 al 1914. Tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Storia, relatore Albero Mario Banti.
- Ministero di agricoltura, industria e commercio. 1911. Le organizzazioni operaie cattoliche in Italia. Officina poligrafica italiana.
- Passoni Adolfo. 1991. Elena da Persico: una donna nella storia. Roma, Ave.
- Pucci Idanna. 2022. “Cora Slocomb Savorgnan di Brazzà: An Artisan of Peace and Social Justice”. In Elena Laurenzi, Manuela Mosca (eds), A Female Activist Elite in Italy (1890-1920): Its International Network and Legacy. Cham, Palgrave Macmillan, pp. 93-129.
- Salini Andrea. 2011. “La «Protezione della giovane» e le congregazioni religiose nel Nord Italia”. In Fondazione «Emanuela Zancan» (a cura di), Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano. Padova, Fondazione E. Zancan Onlus, pp. 198-212.
- Salvioni Giovanni Battista. 1883. “Posta rurale”. Giornale degli eruditi e curiosi, a. 1, II, 15 set., pp. 650-651.
- Salvioni Giovanni Battista. 1898. Rosa Schiratti Salvioni. Ricordi biografici. Padova, Fratelli Gallina.
- Scardozzi Mirella. 2006. “L’istruzione femminile a Pisa e provincia nell’Ottocento”. In Fusano Guarini Elena; Galoppini Annamaria; Peretti Alessandra (a cura di). Fuori dall’ombra. Studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli xix e xx), collana Studi Pisani Cultura e società, 24. Pisa, Plus, pp. 155-206.
- Schiratti Gaetano. 1872. Banca mutua popolare di Pieve di Soligo, Resoconto del primo esercizio, chiuso al 31 dicembre 1871. Treviso, Luigi Priuli.
- Schiratti Giuseppe. 1964. Una comunità in cammino. Treviso, Longo e Zoppelli.
- Toniolo Gianni (a cura di). 2013. L’Italia e l’economia mondiale. Dall’Unità a oggi. Collana storica della Banca d’Italia, Serie contributi, vol. XII. Marsilio editore. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-storica/contributi/contributi12/index.html. Accesso 20/07/2024.
- Toniolo Giuseppe. 1902. “Il lavoro notturno delle donne in Italia”. Rivista internazionale di scienze sociali. x, xxx, 117, set., pp. 3-10.
- Toniolo Giuseppe. 1952. Giuseppe Toniolo. Lettere 1. 1871-1895. Comitato Opera Omnia di G. Toniolo (a cura di). Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana.
- Toniolo Giuseppe. 1953. Giuseppe Toniolo. Lettere 1II. 1904-1918. Comitato Opera Omnia di G. Toniolo (a cura di). Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana.
- Tramontin Silvio. 1991. Prefazione. In Passoni Adolfo, Elena da Persico: una donna nella storia. Roma, Ave, pp. 5-7.
- Vistalli Francesco. 1954. Giuseppe Toniolo. Roma, Comitato Giuseppe Toniolo.
FONTI ARCHIVISTICHE
- Archivio Agostini Venerosi della Seta Marcello. Pisa. L’archivio conserva più di quattrocento lettere di Maria Schiratti e documenti dell’associazionismo femminile pisano.
- Archivio Elena Da Persico. Affi (VR). L’archivio conserva circa una ventina di lettere di Maria Schiratti e una decina di minute a lei indirizzate, relative al movimento cattolico femminile. Sono presenti anche una quarantina di lettere di Toniolo e una ventina di minute a lui indirizzate, alcune delle quali inedite.
- Archivio Giuseppe Toniolo. Pisa. Il Fondo, non ancora ordinato, conserva documenti donati dagli eredi nel 1966 e, tra questi, una parte della corrispondenza familiare e documenti riguardanti la questione femminile.
- Archivio Famiglia Mazzei. Castellino in Chianti (SI). Nell’archivio sono presenti alcune lettere di Schiratti e di Toniolo alla madre dell’economista Jacopo Mazzei.