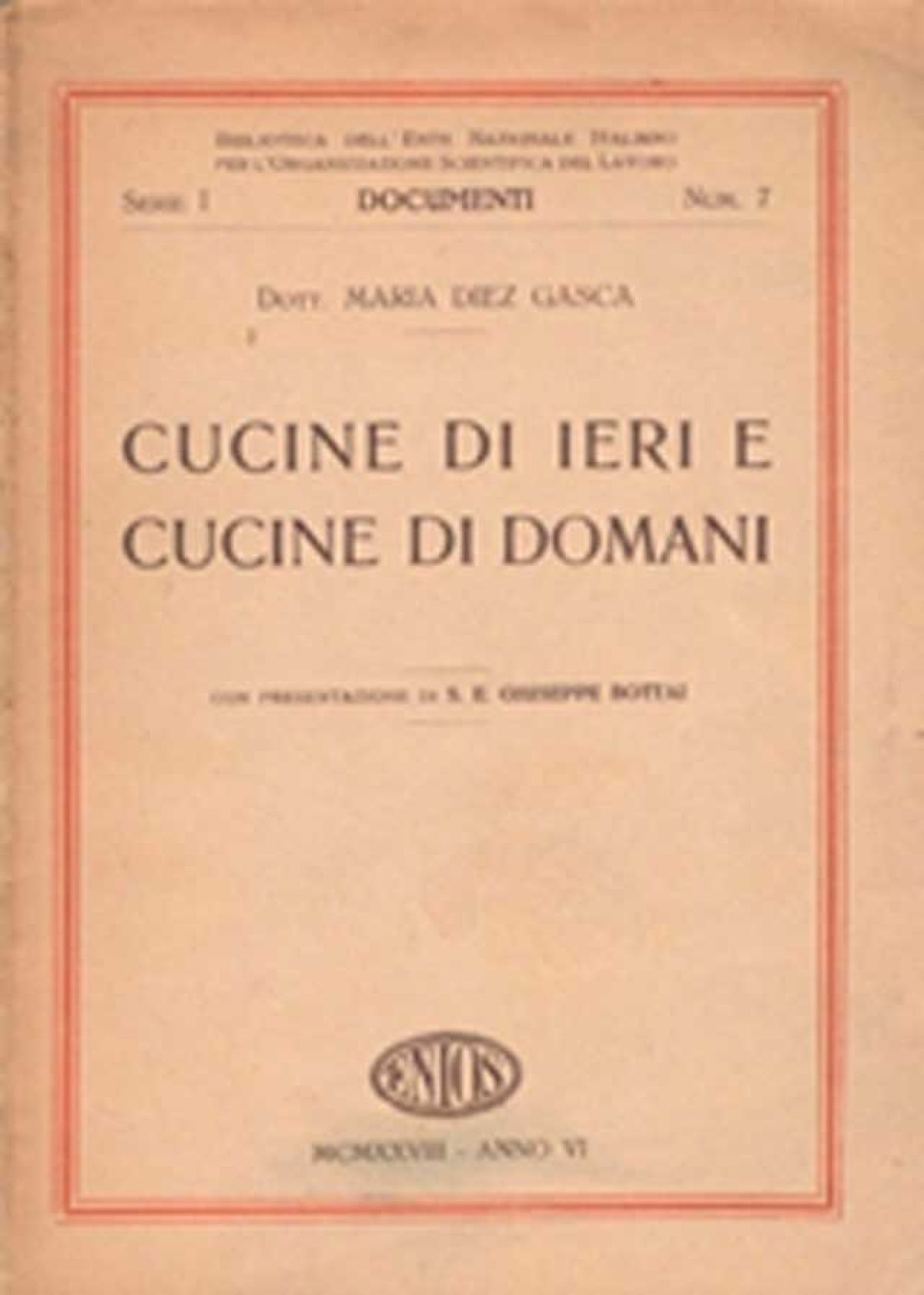Maria Gasca Diez introdusse tra le prime in Italia i precetti della Home Economics, disciplina scientifica nata negli Stati Uniti a cavallo tra Otto e Novecento con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della casa. Figura tra le più attive e autorevoli in questo campo, Gasca Diez mirava alla promozione di una maggiore consapevolezza del valore sociale ed economico del lavoro domestico, attribuendo alla donna un ben definito ruolo all’interno della famiglia e della società italiane dell’epoca.
Figlia di un imprenditore piemontese, nel 1905 Maria Gasca si laureò in Medicina e chirurgia a Torino, specializzandosi poi in medicina del lavoro. A Torino svolse l’assistentato medico e chirurgico presso gli ospedali Mauriziano e San Giovanni e quello ostetrico-ginecologico presso la Regia clinica ostetrica. Dopo aver contratto matrimonio con il medico algherese Salvatore Diez (collega alla facoltà di Medicina di Torino), Gasca Diez si trasferì a Roma, dove svolse compiti di crescente responsabilità fino al secondo dopoguerra. Fu incaricata dal Comune capitolino di svolgere la funzione di medico scolastico (1914) e dalla Croce Rossa Italiana di occuparsi dei servizi sanitari dei bambini (1920). Nel 1921 istituì a Roma un Ufficio di studio per l’orientamento professionale nelle scuole, mentre nel 1925, negli anni del Governatorato, diresse il Gabinetto di psicotecnica presso l’Ufficio del lavoro – che aveva come obiettivo quello dell’orientamento professionale degli alunni e delle alunne che frequentavano le scuole elementari (Barucci et al. 2024, 289-290).
Quello della formazione e dell’orientamento professionale fu uno degli argomenti di maggior interesse per Gasca Diez, oggetto di gran parte delle sue pubblicazioni. L’attenzione era rivolta soprattutto ai più giovani. In questo ambito rientrava anche l’esperienza maturata nell’organizzazione delle scuole all’aperto di Roma, per le quali le era stata affidata la stesura delle linee guida (Gasca Diez e Nobile Ventura 1925). L’amministrazione della Capitale si scontrava fin dall’immediato primo dopoguerra con le disastrose condizioni dell’infanzia, che Gasca Diez ben conosceva anche grazie ad un’inchiesta condotta sul campo nel 1921, presso i quartieri più poveri della città. Agli occhi degli amministratori locali e della stessa Gasca Diez, le scuole all’aperto rappresentavano una possibile soluzione per combattere quelle debolezze psicofisiche determinate prima di tutto da condizioni igieniche carenti, maturate all’interno di abitazioni sovraffollate e fatiscenti. L’approccio adottato da Gasca Diez aderiva pienamente ai dettami sostenuti dalla principale letteratura europea ed americana dell’epoca, che nella profilassi vedeva tanto un investimento sociale quanto economico, per l’impatto positivo che avrebbe avuto sulle finanze pubbliche. A questo si aggiungeva l’assenza di un qualsivoglia progetto di irreggimentazione dei bambini e delle bambine nelle istituzioni fasciste, elemento che segnava una importante differenza rispetto ad alcune esperienze successive (Lunadei 2016, 45-69). Fu in questa fase che Gasca Diez si avvicinò all’organizzazione scientifica del lavoro, corpus di dottrine e ricette organizzativo-manageriali che, grazie al movimento progressista statunitense, gradualmente si stavano estendendo dalla fabbrica verso altri ambiti (compresa l’educazione), in quanto simbolo di efficienza ed eliminazione dello spreco (Flanagan 2007). Dal 1922 al 1924 Gasca Diez fece parte, insieme al marito Salvatore Diez, del Comitato romano per l’organizzazione scientifica del lavoro, le cui attività coincisero con la costituzione di un Laboratorio per l’orientamento professionale e della Scuola professionale di Roma – che anticipava il Servizio di orientamento professionale voluto dal Governatorato (Lombardo, Pompili e Mammarella 2002, 83-84, 122-123).
Oltre all’interesse per il taylorismo, nell’approccio all’educazione di Gasca Diez emergeva anche un modello sociale e famigliare strutturato gerarchicamente. Sebbene fosse sensibile alla promozione culturale e professionale delle donne, Gasca Diez ne immaginava un preciso ruolo. Tra le attività svolte nelle scuole all’aperto, infatti, agli alunni era destinata la gestione finanziaria delle entrate e delle uscite, mentre alle alunne l’assistenza in cucina e il servizio durante i pasti. Tale impostazione, poi replicata anche quando Gasca Diez si sarebbe occupata della più generale modernizzazione dell’ambiente domestico, non era una novità ed era già emersa in precedenza. L’occasione propizia era stata quella della presentazione di uno schema di riforma della scuola media avvenuta nel 1912 a Torino, durante un convegno organizzato dal Consiglio nazionale delle donne italiane. Per le ragazze che non potevano permettersi di proseguire gli studi, Gasca Diez immaginava un percorso triennale il quale, sulla base dei più aggiornati precetti sull’igiene, doveva educarle al loro futuro ruolo di mogli e madri. La gestione della casa, tuttavia, rimaneva nell’orbita anche delle ragazze appartenenti ai ceti più abbienti, cioè quelle che potevano permettersi un futuro sui banchi di scuola e, quindi, una professione. Gasca Diez, infatti, auspicava anche per loro la partecipazione ad un corso integrativo di igiene domestica, propedeutico allo svolgimento di quelle mansioni domestiche alle quali avrebbero dovuto comunque adempiere anche se impegnate in un lavoro fuori casa (Lunadei 2016, 121).
Gasca Diez affiancò all’attività professionale e di organizzazione e direzione di diverse istituzioni pubbliche anche quella di studiosa e pubblicista, contribuendo non solo alla conoscenza e alla divulgazione di temi legati all’educazione e alla formazione, ma anche a quello, in parte connesso, della gestione dell’ambiente domestico. L’interesse più generale di Gasca Diez nei confronti dell’organizzazione scientifica del lavoro e, in particolare, della Home Economics, disciplina scientifica nata negli Stati Uniti a cavallo tra XIX e XX secolo, merita particolare attenzione. Oltre ad essere uno dei quattro componenti italiani del Comitato permanente della International Federation for Home Economics (IFHE), con sede a Friburgo (Germania), Gasca Diez fu la prima, nel 1927, ad introdurre il tema in Italia, organizzando a Roma, come Segretaria generale, il IV Congresso internazionale di economia domestica. Conosciuta negli Stati Uniti con il nome di Home Economics, l’economia domestica si era trasformata in una vera e propria scienza. Insegnata nelle principali università d’Oltreoceano, che formavano nuovi professionisti (gli home economist) capaci a loro volta di dare origini a nuove professioni e discipline scientifiche (Stage and Vincenti 1997), la Home Economics mirava a gestire la casa in modo efficiente, seguendo i principi più aggiornati dell’economia.
Quella di Roma, che nello stesso anno aveva visto anche l’organizzazione del III Congresso internazionale di organizzazione scientifica del lavoro, si presentava quindi come la migliore occasione per far conoscere anche alle donne italiane le potenzialità dell’organizzazione scientifica del lavoro applicata all’ambiente domestico. La Home Economics, tuttavia, arrivava in Italia trovando un contesto economico e sociale lontano da quello americano. Non si trattava solo di un differente standard di vita (De Grazia 2005, 75-129; Scarpellini 2008, 87-128). Anche la considerazione della posizione che la donna avrebbe dovuto occupare all’interno della famiglia e della società era differente (De Grazia 1992). Questi aspetti impattavano profondamente sull’ambiente domestico e su tutte le sue componenti, da quelle organizzative a quelle lavorative, estendendosi inevitabilmente anche fuori dalle mura di casa.
Il programma del Congresso romano prevedeva tre sezioni. La terza era dedicata in modo particolare alle nuove applicazioni scientifiche (Cervesato 1928) e tra le relatrici annoverava esponenti di spicco della Home Economics come le americane Christine Frederick (Williams Rutherford 2003) e Lillian Moller Gilbreth (Lancaster 2004), entrambe protagoniste del processo di modernizzazione dell’ambiente domestico avviato negli Stati Uniti in quello scorcio di secolo. È importante sottolineare come la maggioranza degli interventi congressuali avessero come punto di riferimento le donne dei ceti subalterni, alle quali la stessa Gasca Diez guardava con interesse. Si trattava di una sostanziale differenza rispetto all’approccio tenuto da autrici italiane coeve (Morozzo Della Rocca 1928) o di poco successive (Morelli 1931) le quali, come emerge leggendone i contributi, offrivano un modello destinato a donne appartenenti quantomeno ad un ceto medio, in grado di accedere anche a consumi nuovi e costosi come quelli dei nuovi dispositivi elettromeccanici labour saving (Paris, 2023, 15-41).
Diversi sono gli elementi di riflessione emersi dal confronto congressuale, sui quali anche Gasca Diez avrebbe concentrato alcune delle proprie considerazioni successive. In primo luogo, la consapevolezza della centralità dalla donna nelle dinamiche del capitalismo novecentesco, sia in termini di apporto lavorativo extradomestico (con la conseguente necessità di conciliare il lavoro in casa con quello fuori casa) sia in termini si impatto sulla struttura dei consumi (a partire dalla responsabilità nella gestione di una parte consistente delle risorse famigliari).
La stessa Gasca Diez partecipò attivamente ai lavori con un proprio intervento, presentato a nome di tutto il Comitato organizzatore. Il focus era su uno dei temi cari alla relatrice, ma di grande interesse anche per il regime fascista, come quello dell’educazione e della formazione (Cervesato 1928, 700-2). In particolare, Gasca Diez affrontava il caso della Scuola superiore di economia domestica, iniziativa che rientrava perfettamente nel programma di quella che lei stessa definiva “rivoluzione fascista”, ma che di riflesso andava ben al di là della singola iniziativa, impattando sulla più generale condizione lavorativa femminile (Gasca Diez occupava anche la posizione di direttrice provinciale del dopolavoro femminile di Roma). Nel testo dell’intervento cominciava infatti a delinearsi il profilo di una donna impegnata soprattutto nel lavoro in casa, con la possibilità di un’occupazione extradomestica solo in contesti coerenti con quelle che, secondo il fascismo, erano le principali attitudini femminili. Se proprio doveva esserci, dunque, il lavoro fuori casa delle donne italiane doveva essere circoscritto ad un insieme di occupazioni ben definite.
Dalle conclusioni del Congresso emergeva infine quello che doveva essere lo strumento per raggiungerne gli obiettivi: la piena applicazione della scienza alla gestione della casa. Non solo biologia e chimica, psicologia ed economia, ma anche meccanica ed elettricità in tutte le loro declinazioni e applicazioni (Archivio Storico dell’Unione Femminile Nazionale, b. 7, f. 48, Quadro dei voti enunciati nella seduta di chiusura del Congresso di economia domestica, 17 Novembre 1927, 14-5). La tecnologia giocava pertanto un ruolo importante almeno quanto una migliore organizzazione del lavoro e dello spazio domestico. Scienza, tecnologia e organizzazione dovevano quindi concorrere per alleggerire il lavoro della casalinga dal punto di vista dello sforzo fisico e mentale, ma anche per favorire il risparmio di tempo e di denaro. Il destino della donna, tuttavia, restava sempre l’ambiente domestico – come la stessa Gasca Diez ebbe modo di ribadire l’anno successivo, in una missiva inviata direttamente a Benito Mussolini per sostenere il progetto di un istituto per l’economia domestica (Lunadei, 122). Quanto veniva migliorato e risparmiato andava sempre destinato e investito nella cura della famiglia e della casa, nel miglioramento del benessere fisico, morale e materiale delle sue componenti. In questo, dunque, stava il contributo che la donna avrebbe potuto dare alla modernizzazione dell’Italia fascista.
Il 1927 fu un anno importante per Gasca Diez anche per la pubblicazione del manuale Cucine di ieri e cucine di domani, l’unico volume dedicato al tema dello Scientific Management applicato all’organizzazione della casa e del lavoro domestico (Gasca Diez 1927). Tra le pagine emerge chiaramente il punto di vista di Gasca Diez sul lavoro femminile: la possibilità di un’occupazione extradomestica non doveva interferire con quello che lei stessa considerava il compito principale di ogni donna, ossia occuparsi della famiglia e della casa. L’ambiente domestico era il luogo in cui la donna poteva svolgere pienamente il proprio servizio anche a favore della collettività. Il fascismo vedeva le donne come parte di un progetto totalitario che comprendeva tutta la società, inclusa la sfera privata. La famiglia, in una versione patriarcale e gerarchica, era considerata uno dei pilastri dell’ideologia fascista e la donna ne ricopriva il ruolo di custode. Ecco perché, così come tutte le altre figure professionali, anche la casalinga doveva essere adeguatamente formata. Lo strumento principale erano i corsi di economia domestica, per i quali Gasca Diez si auspicava l’obbligatorietà. Il volume, tuttavia, fu l’occasione anche per sottolineare con forza l’importanza che in questo contesto avrebbe potuto giocare la trasformazione tecnologica della casa. L’ambiente domestico non solo poteva, ma doveva essere dotato di tutti i comfort disponibili. Gasca Diez considerava l’accesso alle innovazioni più aggiornate un vero e proprio diritto per le donne di qualsiasi condizione sociale. Ne emerge una visione estremamente moderna dell’ambiente domestico tanto dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro e dello spazio quanto da quello tecnologico. Scienza, produzione economica e formazione dovevano essere le fondamenta sulle quali costruire la nuova casa fascista.
Il contributo di Gasca Diez alla modernizzazione dell’ambiente domestico, premessa necessaria per il definitivo riconoscimento della centralità della donna italiana nella nuova Italia voluta dal regime fascista, non si esaurì né con l’organizzazione del Congresso del 1927 né con la pubblicazione di Cucine di ieri e cucine di domani. Gasca Diez ebbe modo di argomentare e diffondere il proprio pensiero anche durante la sua importante attività pubblicistica. Nel Gennaio del 1928 fu chiamata a dirigere la rubrica di economia domestica della rivista L’Organizzazione Scientifica del Lavoro. La rivista aveva come editore di riferimento l’Ente Nazionale Italiano per l’Organizzazione Scientifica del Lavoro (ENIOS) e fin dall’anno della fondazione dell’Ente (1926) mirava a diffondere i principi dello Scientific Management. Il coinvolgimento di Gasca Diez non solo ne sottolineava una volta di più la rilevanza nel dibattito sul tema, ma la volontà di estendere il raggio d’azione dell’ENIOS oltre i cancelli delle fabbriche, per entrare nelle case degli italiani. La rubrica fu inaugurata con un articolo nel quale la stessa Gasca Diez ne definiva la linea editoriale: sostenere la razionalizzazione dell’ambiente domestico anche guardando a ciò che stava accadendo oltre i confini nazionali, ma sempre tenendo conto del peculiare contesto italiano. Ciò significava che tale processo doveva essere integrato nel più ampio progetto fascista, con risvolti che dovevano essere non soltanto economici, ma anche di natura morale (Gasca Diez 1928a).
Sempre nel 1928 Gasca Diez si occupò anche della traduzione del volume che Paulette Bernège, fedele discepola dell’americana Christine Frederick, aveva pubblicato in Francia con il titolo De la méthode ménagère (Bernège 1928). Christine Frederick ha rappresentato un punto di svolta nel processo di consolidamento della Home Economics anche al di fuori degli Stati Uniti e i suoi lavori circolarono più di altri in Europa, Italia inclusa. Gasca Diez contribuì attivamente alla diffusione di questi testi non solo traducendo il volume di Bernège, ma, nel 1933, lavorando ad un adattamento al contesto italiano anche di quello della stessa Frederick (Household Engineering. Scientific Management in the Home), utilizzato negli Stati Uniti fin dal 1915 per l’insegnamento del corso omonimo (Frederick 1933).
L’esperienza di Gasca Diez come responsabile della rubrica di economia domestica de L’Organizzazione Scientifica del Lavoro durò solo un anno, un tempo comunque sufficiente per ribadire l’importanza dell’azione portata avanti dal fascismo nel campo dell’educazione femminile (Gasca Diez 1928b). Non si trattava né di una riduzione di interesse per il tema né di un ridimensionamento per Gasca Diez. Nel 1929, infatti, l’ENIOS decise di affidarle la direzione di una nuova rivista specializzata: Casa e Lavoro. L’obiettivo più ampio era quello di agire anche sulla funzione della famiglia e delle sue singole componenti, per renderle più funzionali agli obiettivi del fascismo.
Casa e Lavoro non poteva che guardare con interesse alla Home Economics di matrice statunitense, con particolare attenzione ai lavori della già citata Christine Frederick. Il suo best seller del 1913, The New Houskeeping. Efficiency Studies in Home Management, già tradotto in italiano nel 1928, fu riproposto a puntate sulle pagine della rivista in forma di manuale pratico e illustrato, a cura proprio di Gasca Diez. Con questa iniziativa si voleva verosimilmente raggiungere un pubblico più ampio di quello che poteva accedere tanto al volume originale quanto alla traduzione edita dalla torinese Sit (Frederick 1928). Pubblicata fino al 1935, Casa e Lavoro ha rappresentato il principale tentativo di conciliare una visione scientifica e razionale della casa e del lavoro femminile con i più tradizionali ideali di una donna che, sebbene inserita in un contesto domestico meno degradante rispetto al passato, fosse soprattutto moglie e madre esemplare, nonché amministratrice della ricchezza prodotta dal lavoro extradomestico maschile.
Per concludere sul tema del lavoro femminile, è significativo ricordare quanto scritto da Gasca Diez nel 1936 sulla rivista Difesa Sociale – per la quale collaborava anche il marito Salvatore Diez (Diez Gasca, 1936). La posizione nei confronti del lavoro extradomestico non era mutata nella sostanza: laddove presente, non doveva interferire con quello che era il compito principale di ogni donna, ovvero occuparsi della famiglia e della casa. I toni utilizzati erano però più leggeri di quelli impiegati quasi un decennio prima, nella stesura del volume Cucine di ieri e cucine di domani, le considerazioni meno nette e le argomentazioni più articolate. Gasca Diez faceva altresì un elenco di impieghi e professioni che, in quanto ritenuti tipicamente femminili, potevano essere svolti anche dalle donne. Ciò che merita di essere sottolineato è che questo elenco, di fatto, ricalcava quello che il regime avrebbe stilato qualche anno dopo per un provvedimento legislativo pensato per disciplinare in maniera puntuale il lavoro femminile nei settori pubblico e privato (Regio Decreto n. 898 del 29 Giugno 1939).
Nel secondo dopoguerra Gasca Diez abbandonò il tema della Home Economics continuando ad occuparsi di formazione ed orientamento professionale. Diresse corsi di orientamento promossi dal ministero della Pubblica istruzione dal 1945 al 1949, anno in cui fu eletta nel Comitato direttivo dell’Unione Donne Italiane (UDI), e continuò a pubblicare i suoi lavori fino agli anni Sessanta. Il ritratto professionale di Gasca Diez evidenzia l’apporto che funzionari e professionisti di matrice liberal-democratica diedero al fascismo, occupando importanti ruoli direttivi. Il contributo offerto da Gasca Diez nelle diverse amministrazioni che si sono avvicendate a Roma tra inizio Novecento e secondo dopoguerra (liberali, fasciste e poi repubblicane) testimonia dunque una certa continuità professionale all’interno di evidenti discontinuità politico-istituzionali. Un contributo che, in primo luogo, guardava alle classi popolari (e soprattutto alle donne e alle giovani generazioni) da una duplice angolatura: quella dell’amministrazione pubblica e quella delle associazioni femminili presenti sul territorio. La competenza era senza dubbio una delle spiegazioni di questa continuità, in modo particolare nell’immediatezza della transizione da un’amministrazione all’altra, ma non mancarono anche importanti sovrapposizioni con il pensiero politico prevalente.
OPERE
Pubblicazioni
- 1915. Importanza sociale del bambino. Torre Pellice: Tipografia Alpina A. Coïsson.
- 1920. Le colonie profilattiche estive della Croce Rossa Italiana per il 1920. Roma: Croce Rossa Italiana.
- 1923. La scelta del mestiere. Bologna: Zanichelli.
- 1925 (con Nobile Ventura, Giovanni). La nuova scuola all’aperto. Relazione alla Commissione nominata dal Regio Commissario per il riordinamento della scuola all’aperto. Roma: Cecchini.
- 1926. Rilievi antropometrici e clinici sugli alunni dell’Istituto, anno scolastico 1924-25. Roma: RINIP.
- 1927. Cucine di ieri e cucine di domani. Roma: ENIOS.
- 1928a. “Il movimento italiano per l’economia domestica”. L’Organizzazione Scientifica del Lavoro, n. 1.
- 1928b. “Un consultorio per l’economia domestica a Roma”. L’Organizzazione Scientifica del Lavoro, n. 5.
- 1932. Contributo allo studio per la scelta razionale degli impiegati. Bologna: Stabilimenti Poligrafici Riuniti.
- 1932. Nuovi reattivi giocattoli: i monumenti italiani. Roma: Tip. Terme.
- 1936a. Valutazione dell’intelligenza: metodo per l’uso di reattivi psicotecnici nella scuola. Bari, Bologna, Milano: Vallardi.
- 1936b. “Nuove professioni femminili”. Difesa Sociale. Rivista di Igiene, Previdenza e Assistenza, 10.
- 1940. Orientamento professionale. Roma: Pallotta.
- 1949. Relazione al 9° Congresso internazionale di psicotecnica (Berna, Settembre 1948): Ricerca sulla personalità dei giovani licenziati del Liceo Classico). Roma: Istituto di Psicotecnica e Orientamento Professionale.
- 1952. Che professione può scegliere mio figlio? Roma: Enaoli.
- 1952. Orientamento professionale e scolastico. Roma: Demos.
- 1956. La preparazione del medico per l’esercizio dell’orientamento professionale. Roma: Istituto di Medicina Sociale.
- 1956. Misuriamo l’intelligenza dei nostri bambini. Brescia: La Scuola.
- 1956. I cattivi scolari. Genova, Roma: Demos.
- 1960. L’avvenire dei nostri figliuoli. Farigliano: Nicola Milano.
- Quale professione deve scegliere mia figlia? Consigli ai genitori, agli insegnanti, alle giovanette che han terminato la scuola elementare [Mu.S.Ed. – Museo della Scuola e dell’Educazione “Mauro Lang”, fondo Gino Ferretti, Misc.A.2/6].
Attività a carattere economico
Traduzioni
- Bernège, Paulette. 1928. Come debbo organizzare la mia casa (traduzione di Maria Gasca Diez). Torino, Sit, 1928.
- Frederick, Christine. 1933. La casa moderna. Come risparmiare tempo, fatica, denaro (traduzione di Maria Gasca Diez). Roma, ENIOS.
Manoscritti e altri documenti
BIBLIOGRAFIA
- Barucci, Piero et al. (a cura di). 2024. Scrittori e scrittrici di economia nel Regno d’Italia. Roma, Bancaria Editrice.
- Cervesato, Arnaldo (a cura di). 1928. Atti del IV Congresso di economia domestica. Roma, Tipografia del Littorio.
- De Grazia, Victoria. 1992. How Fascism Ruled Women. Italy, 1922-1945. Berkeley, University of California Press.
- De Grazia, Victoria. 2005. Irresistible Empire. America’s Advance Through Twentieth-Century Europe. London, Cambridge (Mass.), The Belknap Press of Harvard University Press.
- Flanagan, Maureen A. 2007. America Reformed. Progressives and Progressivism, 1890s-1920s. New York, Oxford, Oxford University Press.
- Frederick, Christine. 1928. La donna e la casa. Il taylorismo nella vita domestica (traduzione di Roberto Lorenzo Tealdy). Torino, Sit.
- Lancaster, Jane. 2004. Making Time: Lillian Moller Gilbreth - A Life Beyond “Cheaper by the Dozen”. Boston: Northeastern University Press.
- Lombardo, Giovanni Pietro, Pompili Andrea, Mammarella Valentina. 2002. Psicologia applicata e del lavoro in Italia: studi storici. Milano, Franco Angeli.
- Lunadei, Simona. 2016. “La cura dell’infanzia negli anni del Governatorato”. In Patrizia Gori (a cura di), L’assistenza sociale negli anni del Governatorato di Roma. L’inventario dell’Ufficio Assistenza Sociale (1926-1935). Roma, Viella, pp. 9-139.
- Morelli, Lidia. 1931. La casa che vorrei avere. Come ideare, disporre, arredare, abbellire, rimodernare la mia casa. Milano, Hoepli Editore.
- Morozzo Della Rocca, Elena. 1928. Signorilità. Piacevole trattato di economia domestica di galateo e di mondanità. Lanciano, Carabba Editore.
- Paris, Ivan. 2023. Rileggere il miracolo economico. Gli elettrodomestici tra fascismo e anni Settanta. Roma, Carocci.
- Scarpellini, Emanuela. 2008. L’Italia dei consumi. Dalla Belle époque al nuovo millennio. Roma-Bari. Laterza.
- Stage, Sarah; Vincenti, Virginia B. (eds). 1997. Rethinking Home Economics. Women and the History of a Profession. Ithaca (NY), London, Cornell University Press.
- Williams Rutherford, Janice. 2003. Selling Mrs. Consumer: Christine Frederick and the Rise of Household Efficiency. Athens (NY), London, University of Georgia Press.
FONTI ARCHIVISTICHE
- Archivio Storico Capitolino, Ufficio Assistenza Sociale.
- Archivio Storico Capitolino, Segretariato Generale.